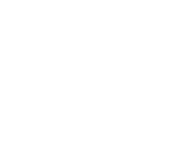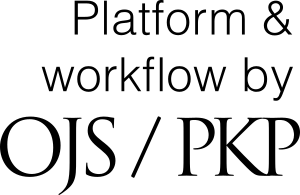Home
L’Annuario Svizzero di Musicologia è una piattaforma di pubblicazione di libero accesso che riflette le tendenze attuali della ricerca musicologica internazionale e svizzera e mira ad attrarre ricercatori e lettori di tutto il mondo. Oltre alle aree tradizionali della musicologia storica, l’Annuario accoglie contributi in ambito antropologico, etnomusicologico, sistematico, teorico e artistico. L’annuario è aperto a proposte interdisciplinari, così come a ricerche provenienti da altri campi scientifici che abbiano attinenza con la musica, e incoraggia collaborazioni e prospettive che intersecano diverse discipline. I formati di pubblicazione variano dagli articoli classici a interviste, podcast e documenti.